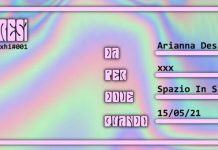Ritratti d’Autore
«Può non piacerci Napoleone ma non è che buttiamo giù le sue statue o i monumenti da lui voluti o a lui dedicati».
Con questa semplice metafora, Peter Eisenman, architetto statunitense di fama mondiale, giunto a Milano per ricevere la laurea honoris causa dall’Accademia di Brera, inquadra perfettamente la questione del Memoriale italiano ad Auschwitz. Un’opera che divide artisti, politici e cittadini in due macrocategorie: chi lo verrebbe smantellare e chi, al contrario, come l’architetto e la stessa Accademia di Belle Arti, lotta per riportarlo in vita.
«Il memoriale non può essere smantellato, né spostato perché – come tutti i lavori artistici, soprattutto se architettonici – ha senso solo nel luogo dove è stato creato. Lo stesso ragionamento vale per il memoriale di Aldo Rossi a Pertini: non puoi prenderlo e metterlo in un garage. Bisogna dare a queste opere la possibilità di “essere”, che ci piacciano o meno. Questo è ciò di cui il mondo è fatto. Noi possiamo prendercene cura, possiamo cercare di spiegarlo ma non possiamo cambiarlo».
Quando lavorava al progetto del Memoriale di Berlino, quali sono stati i problemi che ha affrontato e quali, invece, gli spunti di ispirazione?
Peter Eisenman: «Tutti erano contrari a quel Memoriale. Il governo era contro, la comunità ebraica era contro, la destra e la sinistra erano contro. Ci furono molte polemiche, soprattutto politiche, tanto che si riaccese il dibattito sul problema dell’antisemitismo in Germania. Molti, infatti, accusarono i tedeschi di essere ancora antisemiti. Per mettere a tacere queste voci le autorità si convinsero che il Memoriale andava fatto a tutti i costi. Ovviamente non ne erano del tutto sicure e, perciò, tentarono di cambiare il progetto adducendo che forse non doveva essere come lo aveva progettato Eiseman; magari era meglio qualcosa di più piccolo; oppure sistemato da un’altra parte. E io risposi: “Ho disegnato il Memoriale in questo modo e per questo luogo: lo prendete così o non lo costruite”. Anche se non convinte del tutto, alla fine accettarono. Quando il Memoriale fu inaugurato iniziarono a piovere le critiche, comprese quelle della comunità ebraica che affermò: “Questo monumento non è ebraico”. Io allora chiesi cosa intendessero con questa frase e loro mi risposero che non c’era da nessuna parte la stella di Davide. Ma io non volevo questo genere di opera perché non basta prendere una pietra, metterci sopra la stella di Davide e dire: “Questo è il Memoriale di Auschwitz”. Non funziona così. Non abbiamo mai dato seguito a queste polemiche né aggiunto la stella di Davide. In questo modo, penso, siamo stati in grado di costruire un qualcosa che va al di là di noi, che non ha niente a che fare con Peter Eiseman ma che ha semplicemente a che fare con la storia di ciò che è accaduto».
Le hanno attribuito la paternità del decostruttivismo. L’hanno definita come uno dei protagonisti dell’architettura contemporanea più interessanti e meno comprensibili. Ma Lei ha sempre rifiutato di essere intrappolato in categorie, concetti, definizioni.
P. E.: «Non credo nelle definizioni in genere. Non ho mai usato la parola decostruttivismo: non so cosa sia né cosa significhi. Sarebbe come assegnare la paternità di un bambino. Tu mi dici: “Questo è tuo figlio” e io ti rispondo: “No, questo non è mio figlio” e tu continui a insistere. È una forzatura. Certo, a volte, devi assumerti la responsabilità di alcune cose anche se non sei né madre né padre – e io lo faccio con le cose difficili da capire, quali l’arte e l’architettura, la letteratura e la cinematografia, che non sono per tutti, ma non dirò mai che sono il padre del decostruttivismo. Ho un sacco di figli ma non li riconosco».
Il suo primo viaggio in Italia risale al 1961. Come, quel viaggio, ha influenzato la sua opera e, a distanza di tanto tempo, com’è cambiato il nostro Paese?
P. E.: «Un mio amico e collega statunitense, una volta che tornai a casa, mi disse che sembrava avessi avuto una rivelazione, quasi avessi visto un mondo nuovo. Era parzialmente vero. Per me l’Italia è stata incredibilmente importante per la sua storia, per la sua qualità urbana, per il suo cibo, per il suo modo di essere in generale. Nel 1961 tutti dicevano che in Italia si stava malissimo e che le cose dovevano cambiare. Ma potevi sempre bere un buon caffè e mangiare una buona pasta. Negli anni 90 tutti sostenevano che nel vostro Paese le cose andavano male ma che, prima o poi, sarebbero cambiate. Ma potevi sempre bere un buon caffè e mangiare una buona pasta. Nel 2000 lo stesso discorso. Non si può cambiare il modo in cui è l’Italia, niente cambierà mai. E io adoro l’Italia per questo».
Nel 2015 a Milano si svolgerà l’Expo. Cosa ne pensa? Non crede che quello dell’Expo sia un concetto superato?
P. E.: «L’Expo è un concetto figlio del capitalismo: fare di una capitale un’icona. Tutto ruota intorno all’immagine che bisogna dare del Paese: bisogna far credere che comprare e vendere italiano sia un buon affare. Per queste esposizioni sono state create alcune delle migliori architetture del mondo. Dietro queste fiere ci sono sempre delle buone idee».